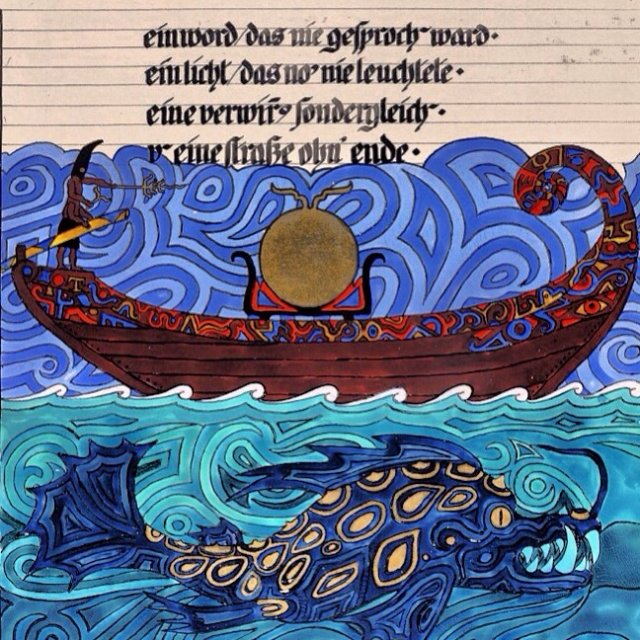 Il paradosso delle persone che si rivolgono alla psicoterapia è che vorrebbero eliminare il dolore, senza perdere la capacità del piacere.
Il paradosso delle persone che si rivolgono alla psicoterapia è che vorrebbero eliminare il dolore, senza perdere la capacità del piacere.
«Quando entra in gioco il dolore le normali leggi dello scambio non si applicano, perché il dolore trascende il valore. Un uomo darebbe via intere nazioni per togliersi il dolore dal cuore, e tuttavia non possiamo comprare niente con il dolore, perché il dolore non ha alcun valore»
(dal film The Counselor, di Ridley Scott, 2013).
Sono le parole di un narcotrafficante, ma potrebbero essere quelle di un saggio. Malgrado le apparenze, il trafficante potrebbe davvero essere saggio, perché la verità che egli afferma non è ristretta al mondo degli affari, illeciti o leciti, ma si estende fino alla ragione per cui le persone cercano il mio aiuto di psicoterapeuta; se non la principale, senza dubbio la prima in ordine di tempo.
Le persone cercano i terapeuti perché sono schiacciate da un dolore che non sono in grado di eliminare da sole. È una circostanza naturale, «togliersi il dolore dal cuore» è come allontanare la mano dal fuoco o ripararsi dal vento gelato.
Tuttavia non è esattamente la stessa cosa.
Se non mi riparo il vento gelato mi uccide, mentre il dolore il più delle volte non uccide.
Il dolore dell’animo è un fattore di crescita dell’essere umano. Le persone che riescono a sostenere l’esperienza del dolore crescono, cioè diventano persone migliori.
In quanto esperienza, l’esperienza del dolore è come tutte le altre: fare esperienza significa imparare, e cambiare. L’esperienza esistenziale è per lo più implicita, nel senso che l’essere umano non sa esattamente cosa gli sta insegnando la vita, ma man mano che vive la vita avverte che il passare del tempo non è uno scorrere insensato.
D’altra parte questo accade alla persona che si lascia trasformare dalla vita. Che, cioè, in ogni circostanza mantiene un elemento di apertura.
La persona che chiude le circostanze, che le definisce troppo, non impara dall’esistenza, e col tempo diviene una persona peggiore.
Il dolore non è tutto uguale. Il dolore iniziale è davvero insostenibile: lo chiamiamo panico, depressione, allucinazione.
Oppure è quello che riguarda la persona amata e al tempo stesso odiata: mi tradisce, mi aggredisce, non capisce, mi umilia, mi abbandona, e io non so che fare, sono in balìa; non la sopporto, la disprezzo, mi fa infuriare, ma non so che fare, non posso fare a meno di lei. Questo dolore è insopportabile, e anche sempre uguale a se stesso; è troppo concentrato, non insegna niente.
La psicoterapia serve a trasformare questo dolore in un altro dolore, che parla e insegna.
Non si può accettare il primo dolore, ma si può lentamente imparare ad amare il secondo.
Se mio padre muore, ho bisogno del mio dolore per la morte del padre. Desidero che il padre venga a trovarmi nei sogni, perché senza la sua presenza vivida, che ormai solo un sogno può darmi, il distacco da lui è ancora peggiore.
Noi non accettiamo il «morire della luce» (Dylan Thomas) e, come afferma un altro personaggio di The Counselor, il commerciante di diamanti, «dichiariamo alle tenebre che non ci lasciamo condizionare dalla brevità della nostra vita. Che noi rifiutiamo di farci sottomettere».
Naturalmente siamo impotenti nei confronti della morte.
Ma il dolore, con la sua assenza di valore, è il ponte verso l’inaccettabile e l’inconcepibile.
Questo è il valore del dolore, l’unica cosa in realtà in grado di far sì che «i saggi conoscano alla fine che la tenebra è giusta» (Dylan Thomas).
Questa tuttavia non è la strategia prevalente per far fronte al dolore. La strategia prevalente oggi è l’anestesia, che nel mio campo significa psicofarmaci.
Il sociologo Ehrenberg sostiene che gli psicofarmaci non sono soltanto uno strumento clinico, ma una strategia sociale, uno stile di vita.
È evidente che ha ragione, vista la loro diffusione.
Dal momento che il dolore non ha alcun valore, deve essere semplicemente eliminato.
Lavoro bene con colleghi psichiatri, e credo che in casi acuti i farmaci siano indispensabili, perché il dolore primario è troppo forte, la persona soffre troppo e non si riesce a lavorare in direzione del significato. Ma questo non significa che il farmaco sia la soluzione ai problemi dell’essere umano. Il farmaco è una soluzione temporanea, poi sarebbe meglio che la persona affrontasse i problemi.
Il farmaco costituisce un tappo per ogni dolore, tuttavia non ogni dolore è patologico.
Di per sé il dolore è un tratto dell’essere umani.
Difatti il dolore del counselor nel film, l’avvocato, è per la morte della donna che ama.
Anche il poeta Machado, come lui, «avrebbe dato ogni parola, ogni poesia, ogni verso che aveva scritto, per avere anche solo un’altra ora con la donna che amava».
Non è possibile amare senza che esista il dolore.
Se non esiste il dolore, non esiste l’amore.
Il dolore che proviamo per tutti coloro che amiamo, e che non ci sono più: genitori, compagni, figli. I partner smettono di amarci, gli amici non vogliono più essere nostri amici, i figli crescono e ci lasciano.
E a quel punto noi soffriamo.
Nessun farmaco ha il potere di eliminare quel dolore; e se lo avesse, noi non saremmo più capaci di amare, perché con l’assenza del dolore il farmaco avrebbe spento anche ogni sentimento.
Il paradosso delle persone che si rivolgono alla psicoterapia è che vorrebbero eliminare il dolore, senza perdere la capacità del piacere. Ma questo non è possibile.
Lo psicofarmaco è un anestetico, e in quanto tale anestetizza tutto, sia il dolore che il piacere.
Più in generale il paradosso consiste nel fatto che le persone si illudono di poter evitare il dolore della vita, senza perdere la vita stessa, cioè la vitalità.
Esistono certamente forme di vitalità esasperate, che chiamiamo «maniacali», in cui apparentemente domina un attivismo e una vitalità estrema.
Ma in effetti si tratta di esistenze analoghe alla tossicodipendenza, perché si fondano sull’aumento costante della dose, o come minimo sulla sua somministrazione continua. Se ho scalato tutti i 4000 del mondo devo scalare i 5000, se ho posseduto 1000 donne ne devo possedere 10.000 (Don Giovanni).
Non è vita, è pseudo-vita.
Il primo dolore che ci segna profondamente, e in un certo senso l’unico, è quello relativo ai genitori, cioè alla loro assenza di amore nei nostri confronti o alla forma distorta e contorta che ha preso il loro amore nei nostri confronti. Su questo Freud aveva profondamente ragione.
Tutta la vita lottiamo per non «guardare in faccia la realtà dell’ambiente della propria infanzia», come scrive la collega freudiana Maria Chiara Risoldi.
Questa realtà è spesso desolante, e molto carente di amore. Ma non vorremmo mai scoprirlo.
Tutta la vita giriamo attorno al non amore che ci ha profondamente feriti e distorti fino da piccoli, quando non ci potevamo difendere e abbiamo dovuto subire un’impronta indelebile che si è depositata nei lunghi anni della nostra plasmabilità.
Se fuggiamo quel dolore la nostra esistenza perderà progressivamente di senso; se lo affrontiamo, dovremo soffrire di nuovo.
Dunque il paradosso dei pazienti è che vengono per smettere di soffrire, e scoprono che per poter stare davvero meglio devono prima sostituire il dolore di superficie con quello profondo; scoprono cioè che sono venuti convinti di eliminare un dolore, mentre in realtà lo devono sostituire con un altro più autentico.
Quando lo avranno attraversato, allora staranno davvero meglio.






























































































































